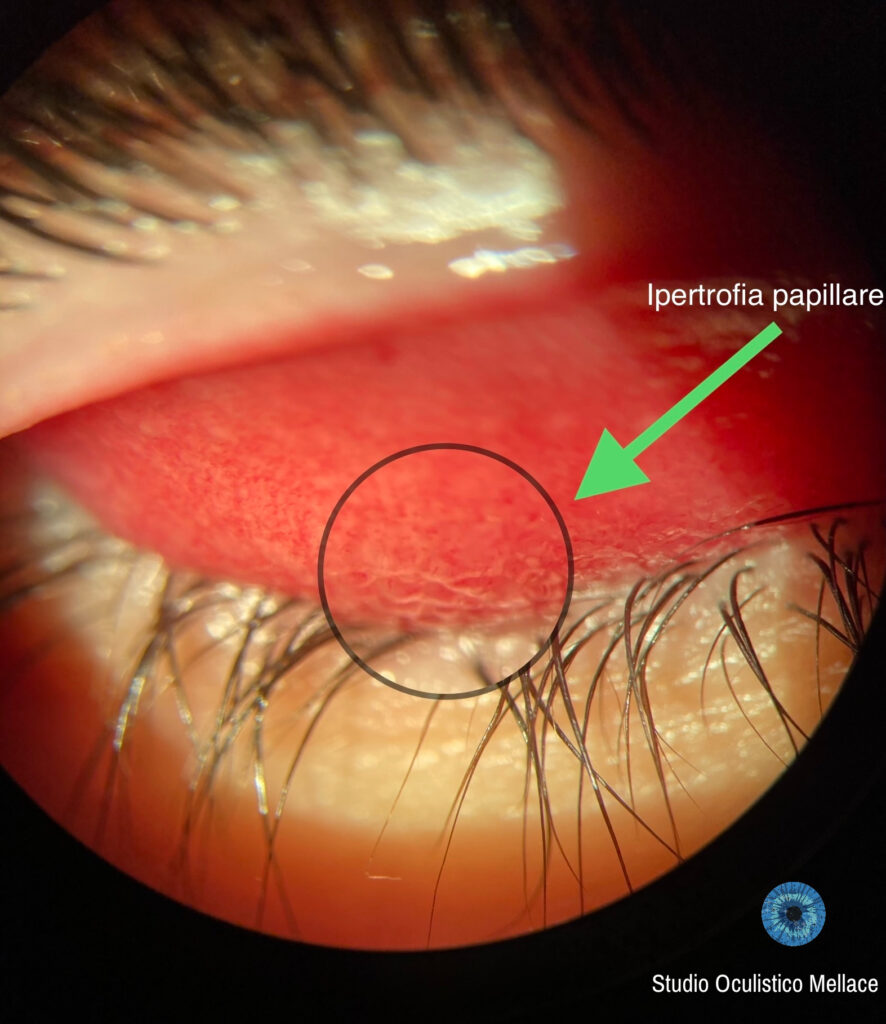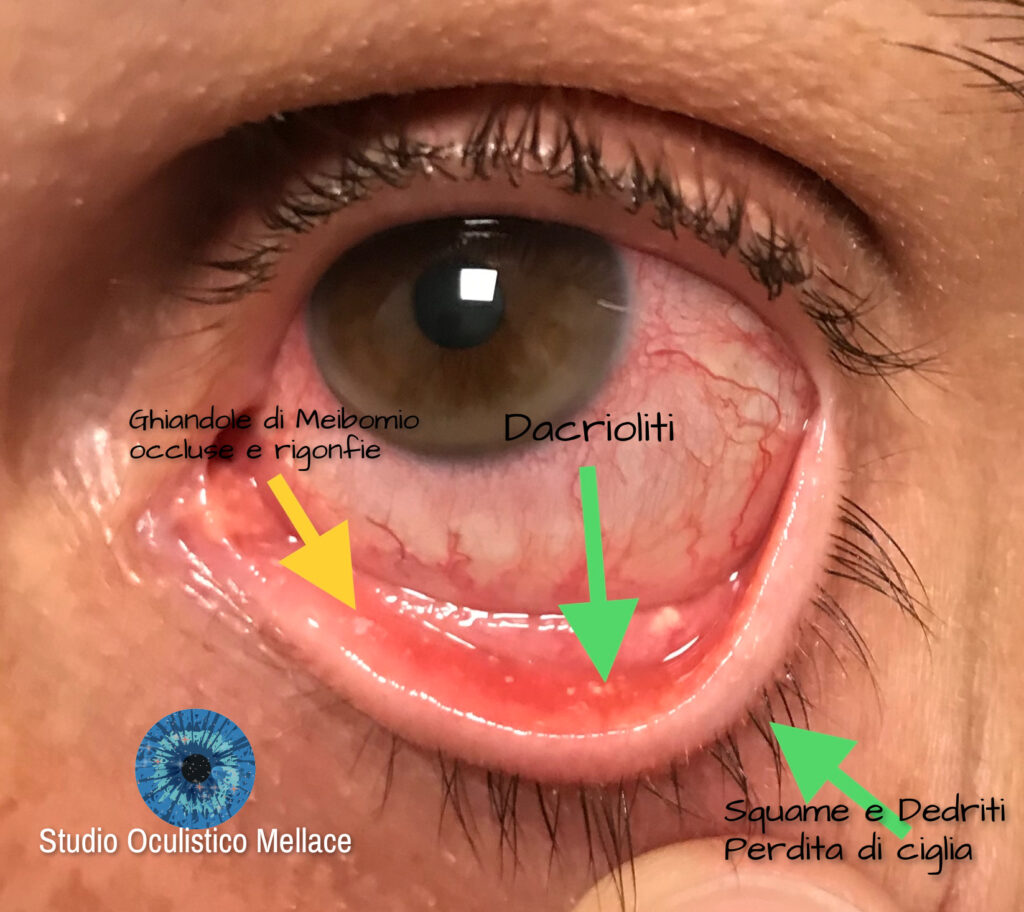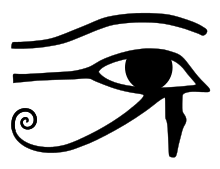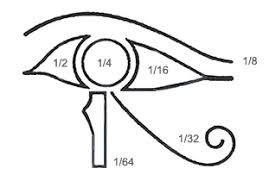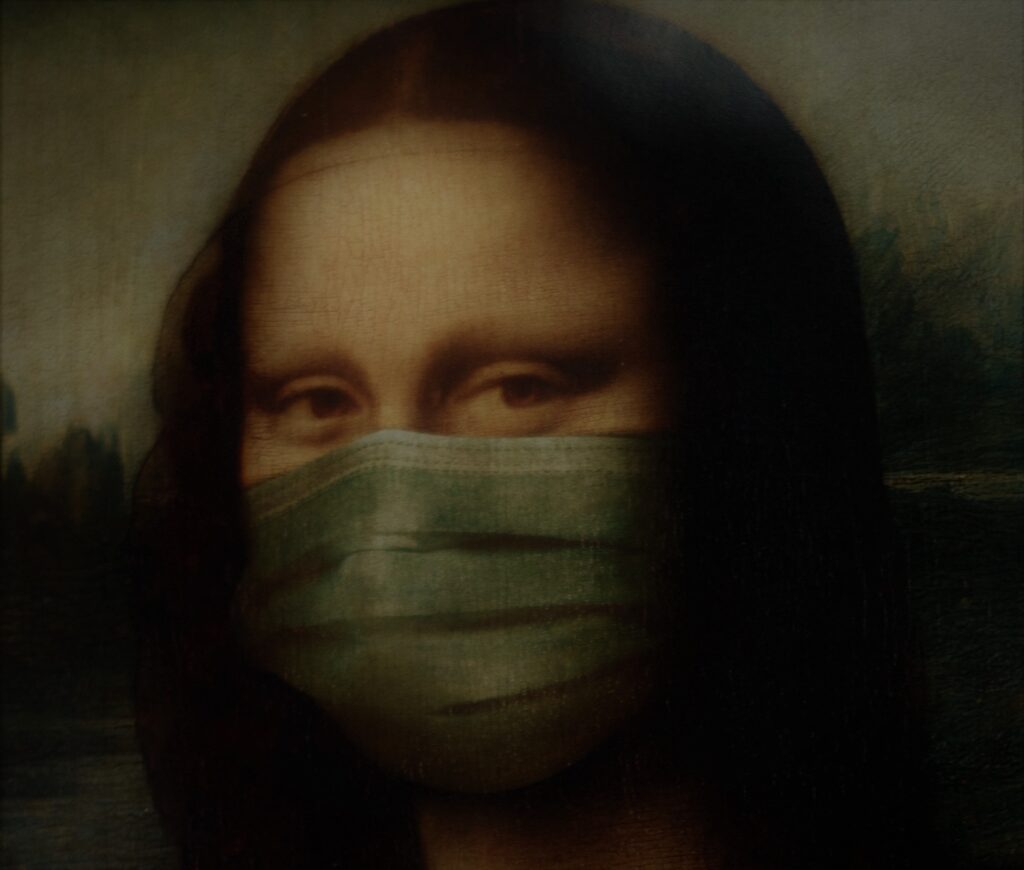Santa Lucia è patrona di Siracusa, degli occhi, degli oculisti, dei ciechi e degli elettricisti. Si festeggia nel giorno del suo martirio.
Lucia era una giovane siracusana di famiglia nobile, orfana di padre. Pregando Sant’Agata per intercedere alla guarigione della madre malata, ebbe una visione della santa che le rispondeva: «Perché chiedi a me quello che puoi ottenere da sola?». Dopo la guarigione della madre Lucia decise di consacrarsi al Signore e destinò tutto il suo patrimonio ai poveri.
Per i successivi anni, visse dunque a servizio di infermi, bisognosi e vedove della città. Il pretendente, rifiutato da Lucia, vedendola privarsi di tutti gli averi, volle vendicarsi denunciandola come cristiana. Erano infatti in vigore i decreti della persecuzione dei cristiani emanati dall’imperatore Diocleziano.
Al processo Lucia si proclamò cristiana, rifiutando di adorare gli dei pagani. Il magistrato dunque ordinò che Lucia fosse costretta con la forza, ma, come narra la tradizione, divenne miracolosamente pesante, tanto che non riuscirono a smuoverla. Accusata di stregoneria, Lucia fu cosparsa di olio, posta su legna e torturata col fuoco, ma le fiamme non la toccarono. Infine fu messa in ginocchio e decapitata, o secondo le fonti latine, le fu infisso un pugnale in gola. Era il 13 Dicembre 304.
L’episodio in cui Lucia si sarebbe strappata gli occhi o le avrebbero cavato gli occhi è assente nelle molteplici narrazioni e tradizioni, almeno fino al secolo XV.
L’emblema degli occhi sulla coppa, o sul piatto, sarebbe da ricollegarsi, più semplicemente, con la devozione popolare che l’ha sempre invocata protettrice della vista a motivo dell’etimologia del suo nome dal latino Lux, luce.
Curiosità
“Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia” è un detto popolare coniato verosimilmente prima dell’introduzione del calendario gregoriano del 1582. Con questo nuovo inserimento veniva colmata la sfasatura tra calendario civile e quello solare che aveva portato a coincidere il solstizio d’Inverno con il 13 dicembre. Da allora il giorno più corto dell’anno (solstizio d’Inverno) venne riportato tra il 21-22 Dicembre. Però per una casuale coincidenza il 13 dicembre è comunque legato ad un fenomeno astronomico, ossia con il giorno dell’anno in cui il Sole tramonta prima. Infatti dopo tale giorno il tramonto avviene ogni giorno più tardi. Nonostante questo, anche dopo il 13 Dicembre le giornate continuano ad accorciarsi; infatti, fino al 21-22 Dicembre, la leggera posticipazione del tramonto è accompagnata da una maggiore posticipazione dell’alba.